
Cosa significa perseverare? Norman Fischer ci spiega perché la Perseveranza è una delle qualità più importanti da coltivare per chi pratica la meditazione.
Cosa significa perseverare
Cosa significa perseverare? Significa che possiamo uscire da una situazione difficile tenendo duro, anche di fronte a molti, veloci e pericolosi cambiamenti. Questa è la pratica della perseveranza, la mia disciplina spirituale preferita. Sebbene non sia molto apprezzata o eccitante, la perseveranza è la più grande di tutte le qualità spirituali, poiché senza di essa tutte le altre qualità – l’intenzione, la visione profonda e i poteri – saranno cancellate non appena la prima pantera, il primo serpente o il primo cinghiale apparirà nelle vicinanze. Si può essere forti, intelligenti, gentili, dire le preghiere ogni giorno, meditare fino a che le gambe si staccano. Si possono avere esperienze spirituali meravigliose, incontrare Dio faccia a faccia, servire il prossimo con compassione e zelo. Si può essere creativi e pieni di talento. Ma se non si è pronti e capaci di resistere quando le condizioni cambiano crudelmente e all’improvviso, la pratica spirituale, per quanto devota e brillante possa essere, sarà in ultima analisi piuttosto inutile. E il cambiamento – il costante mutamento e l’improvviso rovesciamento – che ci mette alla prova, dunque dobbiamo apprezzarlo, e anche non vedere l’ora che arrivi, per quanto sgradevole possa essere alle volte, poiché è grazie a esso che siamo forzati a sviluppare la tolleranza e la perseveranza.
Il carattere cinese per perseveranza è un cuore con una spada che pende su di esso: un altro esempio del modo brillante del linguaggio di mostrarci qualcosa di sorprendente e importante inciso all’interno del significato di una parola. La vulnerabilità è inscritta nei nostri cuori, che possono essere squarciati in ogni momento da qualche improvviso cambiamento nell’organizzazione, da qualche dolore, da qualche orrore, da qualche ferita. Tutti noi sappiamo ciò e ne abbiamo paura, e dunque proteggiamo i nostri cuori coprendoli, non esponendoli. Ma così non funziona. Il coprire il cuore non fa altro che legarlo e soffocarlo fino a che, come una ferita che è rimasta bendata troppo a lungo, il cuore comincia a suppurare e diviene purulento. Alla fine, senza aria, il cuore muore e non si prova più nulla, non si fa più esperienza di nulla.
Perseverare nella vulnerabilità
Praticare la perseveranza vuol dire apprezzare e celebrare la vulnerabilità del cuore, e comprendere che lo squarciarsi del cuore o il sentirlo trafitto non devono essere impediti; vuol dire comprendere che la vulnerabilità del cuore è una cosa buona, in quanto le ferite possono farci sviluppare la pace e il senso di realtà – a patto che si sia disposti a tener duro davanti alla pantera della nostra paura, al serpente del dolore, al cinghiale della vergogna, senza fuggire via e senza essere sbalzati lontano. La perseveranza consiste semplicemente nel tenere duro, con costanza, qualunque cosa accada, aspettata o inaspettata: non fare nulla, non riparare nulla (poiché il fare e il riparare potrebbero essere un modo per coprire il cuore, un modo per evitare ferite e dolori tenendoci occupati con schemi e progetti). Semplicemente tener duro e basta. Tener duro e stare con ciò che è, rende la vita preziosa.
La sopportazione e la perseveranza hanno una cattiva reputazione nella nostra cultura, dove la saggezza convenzionale ci dice che dobbiamo risolvere i problemi, riparare ciò che è rotto, conquistarci ciò che desideriamo, farci sentire, scuotere le cose, farle accadere. E se nessuna di queste cose funziona, allora ci viene detto di cambiare, di andare avanti, di prendere una nuova rotta, di intraprendere qualcosa di nuovo. Ma questo modo di pensare ha senso solo quando stiamo cercando di ottenere una soddisfazione esterna. Non tiene in considerazione il benessere interiore; né ha a che fare con le domande più profonde su chi siamo veramente e su cosa ci fa veramente felici, domande che nessuno può ignorare troppo a lungo. Non c’è bisogno di essere dei saggi o dei filosofi per comprendere che ciò che ci rende felici non ha a che vedere con quello che abbiamo, ma con quello che siamo. E ciò che siamo è qualcosa di proteiforme, cangiante, che cambia costantemente forma, qualcosa di vuoto, e magnifico come un alto albero o una colonna d’acqua – se lo permettiamo. Il prendere rifugio nella nostra mutabilità, nella nostra energia trasformativa interiore, è il modo migliore per trovare la felicità, un tesoro dal valore superiore a qualsiasi altra cosa si possa trarre dall’esterno. Nella misura in cui la perseveranza ci aiuta ad abbracciare questa energia trasformativa, e permette alla magia dell’energia stessa di avere effetto su di noi, non è affatto passiva. E una forza spirituale attiva.
Cosa significa perseverare nello Zen
La pratica Zen ha la reputazione di essere severa e dura, forse perché le persone hanno letto troppi libri sullo Zen – e tra queste c’è anche qualche maestro Zen che forse ha letto troppi libri sullo Zen e dunque crea dei centri che aspirano a riprodurre lo stile Zen di cui si parla in tali libri. Gli antichi monaci cinesi, che vivevano in monasteri di montagna, forse apprezzavano la vita dura, ma l’essenza di ciò che hanno insegnato e praticato trascende la severità e la durezza.
Tuttavia, come la vita, la pratica Zen non è molto facile. In un certo senso, un ritiro Zen – con le sue lunghe ore di pratica seduta silenziosa – costituisce una catastrofe controllata e benigna, ed è garantito che produca un cambiamento intenso e rapido. Ma un maestro Zen duro e un programma di meditazione severo non sono necessari per produrre catastrofi. La vita lo farà per noi naturalmente. Ogni momento è una catastrofe, un disastro totale, una sfida dura e tonificante, se siamo sufficientemente svegli per capirlo. Ogni momento evoca la perseveranza e l’accettazione.
Nei ritiri Zen abbiamo un metodo per lavorare con questi cambiamenti all’argento vivo: sediamo con essi, prestiamo attenzione a essi, ma allo stesso tempo prestiamo attenzione al respiro, al corpo, alla postura, al camminare, allo stare in piedi, al lavare i piatti, e così via. Il rimanere stabilmente ancorati alla presenza mentale mentre attraversiamo tutti i cambiamenti è il modo in cui pratichiamo la perseveranza. E si può adottare lo stesso metodo in ogni luogo e in ogni momento: semplicemente prestando attenzione ai dettagli di ciò che accade internamente ed esternamente. Senza indietreggiare e senza fuggire. Avendo fiducia in ciò che accade. Rimanendo saldi al proprio posto.
La perseveranza del Buddha
Ciò che mi colpisce della storia della ricerca dell’illuminazione del Buddha non è la brillantezza del Buddha o il suo potere meditativo, ma la sua perseveranza di fronte a cambiamenti tremendamente difficili. I fondatori di religioni sono normalmente immaginati come eroi o persone superiori, quindi potremmo naturalmente pensare che il Buddha fu straordinario, che la sua illuminazione fu ricca di profonde esperienze spirituali, che mantenne sempre il controllo. Ma in realtà accadde esattamente l’opposto. Il Buddha passò dei momenti estremamente difficili la notte della sua illuminazione. Tutti i suoi desideri, dubbi e rimorsi, tutte le sue colpe e le sue paure si presentarono a lui in maniera forte e chiara. Nel racconto tradizionale tali sentimenti sono rappresentati da vari demoni e da tentatrici che appaiono in sequenza, terribili e devastanti. Ritengo che il Buddha debba essere rimasto piuttosto sgomento davanti a tutto ciò, forse anche spaventato a morte.
Ciò che salvò il Buddha fu il suo impegno originario a praticare la perseveranza. Con tutta l’equanimità di cui fu capace, rimase seduto sul cuscino da meditazione, praticò la pazienza con tutte le cose colorate che gli comparirono. Alla fine, al punto estremo della sua sofferenza, tenne duro, avendo fiducia nel proprio corpo e nella terra sulla quale era seduto e che lo sosteneva nella sua battaglia. Si arrese alla saggezza della propria carne, frutto della terra, e alla immediatezza del suo corpo, della sua vita proprio dove stava. Facendo ciò, la sua mente si calmò. E dunque si schiuse l’esperienza dell’illuminazione.
In altre parole, il Buddha non creò la sua illuminazione, né la produsse. Semplicemente accadde, come uno sviluppo naturale del tener duro davanti all’avversità estrema. Accadde con la stessa naturalezza con la quale una stella sorge nel cielo. Sebbene nel racconto l’illuminazione sia presentata come un finale momento di realizzazione (le storie hanno sempre bisogno di un prologo, di un conflitto, e, preferibilmente, di un lieto fine), in realtà l’illuminazione del Buddha continuò a dischiudersi giorno dopo giorno, per il resto della sua vita. Ogni giorno, per il resto della sua esistenza, egli continuò la pratica della perseveranza, tenendo duro davanti ai vari cambiamenti che ebbero luogo – il suo mal di schiena e il suo mal di stomaco, le varie dispute e i problemi nel suo Ordine, i regicidi, le guerre, le carestie, le morti, la sua stessa vecchiaia – e così accrebbe la sua esperienza dell’illuminazione, la comprese, la espanse e la approfondì. Anche dopo la morte del Buddha, l’esperienza della sua illuminazione persistette. Proseguì con la perseveranza delle persone con le quali aveva vissuto e praticato, che svilupparono ancor più l’illuminazione del Buddha. E anche oggi ogni persona che pratichi la vera perseveranza, rimanendo stabile davanti ai cambiamenti e alle catastrofi della vita, tenendo duro, senza fuggire, testimonierà allo stesso modo il continuo dischiudersi dell’illuminazione del Buddha.
Da: Norman Fischer, “Tornare a casa. Un commento zen all’Odissea“, Edizioni La Parola, 2010.
Tornare a casa. Un commento zen all’Odissea
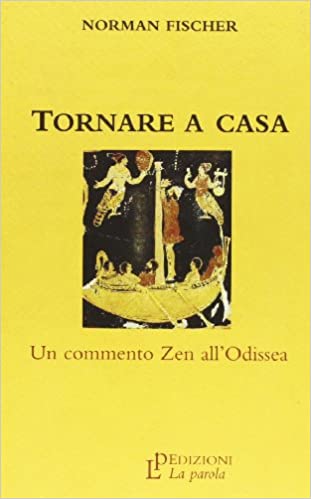
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
You need to login or register to bookmark/favorite this content.



