
Ci chiediamo cosa possiamo fare per cambiare il mondo. Per Stefano Bettera, la domanda da porsi è: cosa posso fare con gli strumenti che ho a disposizione, per alleviare almeno un po’ la sofferenza del mondo?
Spesso cambiare il mondo è un compito inesauribile, perché la sofferenza, il disagio, i problemi si generano ogni giorno, in una catena senza fine. Di guarigione parla Bernie Glassman, fondatore dell’Ordine dei costruttori di pace, gli Zen Peacemakers: tra le varie attività promosse da questa organizzazione c’è anche il ritiro di meditazione nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Ogni anno, nel mese di novembre, decine di persone si ritrovano laddove è seppellito, in una fossa comune, oltre un milione di persone. Ognuno ha con sé un foglio con scritti sopra i nomi dei prigionieri e inizia a recitarli ad alta voce. Quasi nessuno riesce ad arrivare in fondo alla lista. Una volta a Bernie fu chiesto perché si ostinasse a organizzare questi ritiri, se pensava che la semplice presenza fosse sufficiente ad alleviare un dolore così grande, così profondo, così atroce. Lui rispose che certamente era impossibile guarire una ferita cosi profonda, ma essere testimone di quella sofferenza permetteva a chi era lì di iniziare a guarire se stesso.
L’enormità di tragedie come questa ci porta spesso a pensare in termini di “questo non dovrebbe accadere” oppure “non è giusto, è inaccettabile che accada una cosa simile”. Quel che invece dovremmo fare è porci una domanda: «Cosa posso fare con gli strumenti che ho a disposizione, per alleviare almeno un po’ questa sofferenza? Da dove iniziare, qui e ora e non nel migliore dei mondi possibili?».
Deshan, un altro dei grandi maestri zen cinesi delle origini, un giorno si rivolse così ai monaci: «Qui non ci sono Buddha… Realizzare il mistero non è altro che afferrare il senso della vita di una persona comune». Nessuna illuminazione o modello inarrivabile, quindi, nessuna regola, nessun testo sacro. Non si tratta solo dell’approccio ironico tipico del pensiero zen. Deshan era terribilmente serio e voleva solo esortare i monaci a praticare proprio nel cuore della vita. La loro.
Mia mamma, Edda, mi raccontava che da bambina adorava sedersi ai piedi della vecchia radio in cucina e ascoltare le voci che narravano di Paesi lontani. Non c’erano molte distrazioni a quei tempi e la voce di Mussolini era quella della storia che trionfava, la predica di una messa laica. Mamma, con candore, mi confessò che a quell’epoca non aveva alcun dubbio: il Duce era proprio dentro la radio. Quando aveva dieci anni la guerra e la fine del fascismo la strapparono al paese sulle sponde del fiume Enza dove era nata. A dodici già lavorava come apprendista in una camiceria nella zona nord di Milano. La povertà e la politica le avevano rubato l’infanzia, ma non c’era rancore o malinconia in lei. Negli anni i riconoscimenti alla bravura nel taglio e nel cucito non sono mancati ma il suo cuore è rimasto generoso e autentico come la campagna in cui era cresciuta. «Un giorno scriverai per me un racconto intitolato Il Duce nella radio, vero?», diceva con scherzosa autorità, come a voler lasciare una testimonianza discreta del suo passaggio in questo mondo. Poi tornava china su forbici e stoffe, come pentita di quel momento di vanità. Mi stupiva che concepisse il suo lavoro come un’impresa quasi caritatevole. Aiutava chiunque e io talvolta l’ho persino rimproverata per questo. Per tutta risposta, lei faceva spallucce e diceva: «Hanno bisogno». Ormai anziana, quando si accorse che le forze non soddisfacevano più la generosità, si spense. Con lo stesso candore. La voce nella radio non parlava più.
Le scelte, le azioni che contano, non sono dettate da ciò che abbiamo letto sui libri. Non perché lo studio non sia importante, ma perché è superato dalla concreta testimonianza della realtà, il qui e ora. Invece di chiederci qual è la cosa giusta da fare, bisogna andare oltre e agire. Perché non possiamo fare altro che così. La pratica, il sentiero buddhista, in quest’ottica non prevede alternative, anzi ci mette con le spalle al muro, senza giustificazioni.
Poco prima di morire, Gotama lascia ad Ananda, il suo assistente, una sorta di “testamento” spirituale, umano e filosofico che dice più o meno: «Tutto nella vita è destinato a dissolversi, impostate il vostro percorso sulla cura». Questo quindi è il suo insegnamento: non un teorico moralismo, ma un’etica della cura e della gentilezza. Da dove si parte per metterlo in pratica?
C’è una storiella zen che narra di un monaco che viveva in un monastero il cui pozzo si era asciugato. Ogni giorno prendeva un cucchiaio e si recava in cima alla montagna innevata. Raccoglieva un po’ di neve e tornava a valle per svuotarlo nel pozzo. Mai sarebbe riuscito a riempirlo, ma un cucchiaio era tutto ciò che aveva a disposizione. Così faceva, giorno dopo giorno.
Spesso, di fronte alle tragedie, ci sentiamo impotenti, esausti, indignati, perché pensiamo a come il mondo “dovrebbe” essere. Invece faremmo meglio a prendere il cucchiaio e a recarci in cima alla montagna.
Nasir Sobhani – un giovane parrucchiere di Melbourne che dedica un po’ del suo tempo a tagliare i capelli e a truccare i senzatetto – non vuole tagliare i capelli a tutti gli homeless australiani. Lo fa a quelli che incontra. L’incontro è centrale e la sua pratica consiste esattamente nel testimoniare la trasformazione che ne deriva. Allo stesso modo, gli Zen Peacemakers, come altre organizzazioni umanitarie, non hanno la presunzione di guarire tutta la sofferenza del mondo, e quindi partono dalla propria, lavorano sulla reazione che il dolore suscita nei loro cuori per scoprire fino a che punto può scavare nelle loro vite. Così saranno in grado di avere gli strumenti e di agire quando lo incontreranno di nuovo sul cammino. Le lacrime di chi recita i nomi delle vittime del nazismo durante il ritiro ad Auschwitz guariscono la vergogna, la tristezza, sono una resa di fronte al mistero di tanta violenza. Sono le lacrime del Buddha.
Da: Stefano Bettera, “Il Buddha era una persona concreta. Consigli di felicità orientale a uso degli occidentali“, Rizzoli, 2019.
Il Buddha era una persona concreta. Consigli di felicità orientale a uso degli occidentali
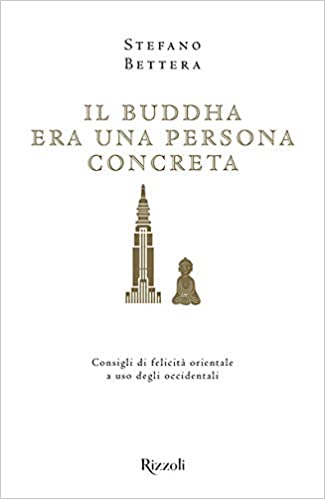
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
You need to login or register to bookmark/favorite this content.



