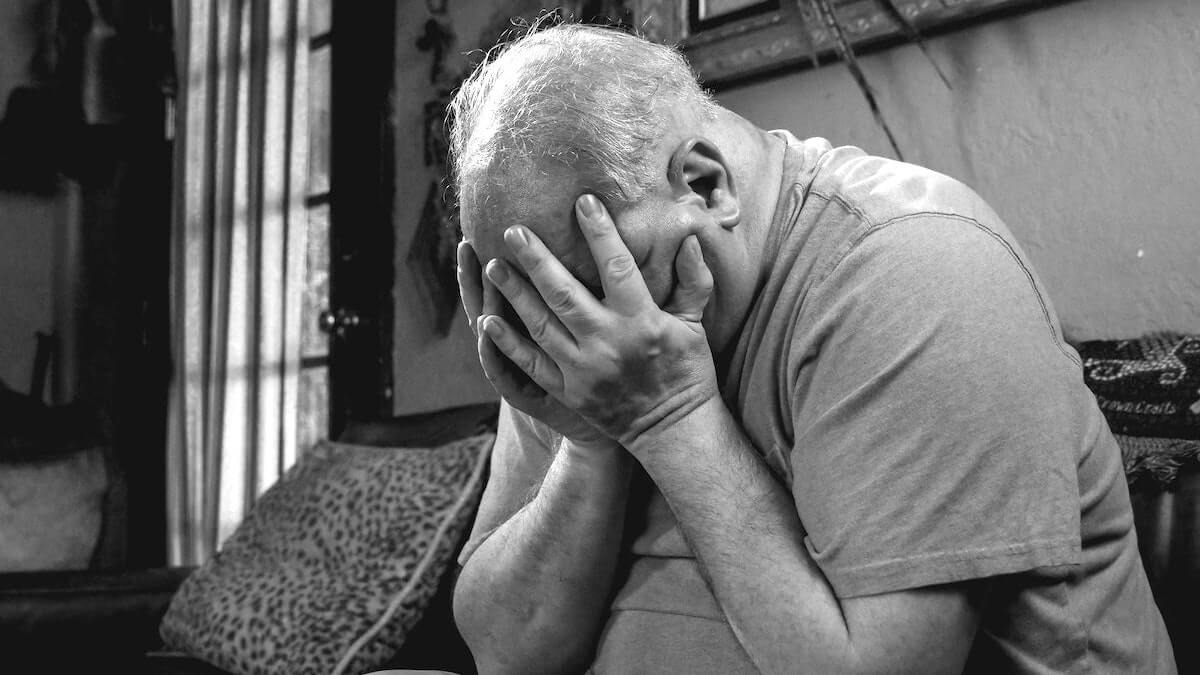
La storica culturale Tiffany Watt Smith racconta di come l’ansia sia considerata un disturbo solo da un centinaio di anni, e di come ansia e angoscia siano termini intercambiabili con una forte accezione culturale.
«L’angoscia è la vertigine della libertà.»
Søren Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia
Lo stomaco si capovolge e la gola si chiude. Le palpebre sbattono e la mente rimbalza attraverso infinite possibilità. A differenza della paura e della preoccupazione, che di solito hanno una causa ben definita, l’ansia (o angoscia*) ronza intorno al buffet dei problemi umani, posandosi su un disturbo ordinario e trasformandolo in una visione catastrofica. Ci rende agitati, ci toglie il respiro. Ci ostacola. E facile riconoscere questa sensazione di compressione e strangolamento nella radice greca della parola: angoscia viene da ang (premere forte, strangolare, essere appesantito dal dolore).
Tutti noi proviamo una forma di ansia o di angoscia, di tanto in tanto. Oggi, però, tendiamo a vederla come un breve episodio privo di senso, qualcosa che va superato e senza dubbio non assaporato. Forse ci vengono in mente certi film con i loro personaggi sudaticci e balbettanti —Jack Lemmon in “A qualcuno piace caldo“, Woody Allen in, be’, quasi tutto — irritabili e debilitati, che immaginano di continuo le peggiori situazioni possibili; potremmo concludere che l’ansia (o angoscia) non fa al caso dei vincenti, o delle persone felici. Ce lo confermano sia l’industria farmaceutica sia quella delle terapie alternative, che ci offrono una varietà di pillole e rimedi, esercizi e meditazioni per calmare la nostra mente ansiosa e renderla “libera”.
Che l’angoscia – o l’ansia – sia vissuta come una terribile maledizione sembra inevitabile nel XXI secolo. Potrebbe sorprendervi, però, scoprire che solo da un centinaio d’anni viene considerata un disturbo, e che prima di allora alcuni filosofi parlavano di paura e angoscia come di reazioni arricchenti di fronte alla scoperta della libertà individuale.
L’idea che l’ansia potesse essere una malattia venne presentata per la prima volta nel 1893, dallo psichiatra di Wiesbaden Ewald Hecker, e due anni dopo dal più noto collega viennese Sigmund Freud. La chiamavano Angstneurose, un nome che secondo Freud offriva un’alternativa più precisa al generico termine “nevrastenia con cui molti pazienti venivano diagnosticati in quel periodo. Tra i sintomi della Angstneurose figuravano l’ipersensibilità al rumore, i terrori notturni, le palpitazioni cardiache, l’asma e la sudorazione eccessiva. Ma un aspetto in particolare dominava il quadro: la cosiddetta “aspettativa ansiosa”, il temere il peggio. Il suo archetipo era una casalinga molto agitata: «Penserà alla polmonite ogni volta che suo marito tossisce quando ha il raffreddore, e nella sua immaginazione si vedrà passare davanti il corteo funebre», scriveva Freud, che considerava tra le principali cause di questa nevrosi «l’accumulo dell’eccitazione», o, in termini moderni, la “frustrazione sessuale”, ragion per cui pensava che le giovani coppie sposate corressero i rischi maggiori. Dal suo punto di vista, i metodi contraccettivi utilizzati in quell’epoca — il profilattico e il coito interrotto — impedivano l’orgasmo femminile. Priva di uno sfogo, la libido di una donna veniva in superficie in maniere bizzarre: le palpitazioni cardiache e il respiro corto di un attacco di panico, per esempio, che Freud vedeva come un sostituto dell’ansimare e sbuffare del sesso. Per Freud, dunque, l’ansia era una forma di libido inacidita, legata all’autentico desiderio «nello stesso modo in cui l’aceto sta al vino».
Negli anni quaranta, in mezzo ai danni psicologici causati dalla guerra, il poeta inglese W.H. Auden sentì il bisogno di parlare di un’«età dell’ansia». Il governo inglese e quello americano tentarono di arginare l’ondata dell’angoscia collettiva, mettendo in campo psicologi perché misurassero e migliorassero i livelli di “serenità” e “sicurezza” della popolazione — un’impresa che somiglia all’imperativo della felicità di oggi. Per quando il Miltown, il primo dei tranquillanti di enorme successo, arrivò sul mercato nel 1955 , seguito dal Valium nel 1963 , l’angoscia (o ansia) era diventata un’industria che fatturava parecchi milioni di dollari, ed era il disturbo psichiatrico più caratteristico del Novecento. Con gli anni sessanta, però, l’età dell’ansia era in declino. Una nuova malattia — un disturbo prima piuttosto raro noto come “depressione” — cominciava a prendere piede, e la cosa era dovuta in parte alle nuove classificazioni diagnostiche, incoraggiate da un’industria farmaceutica in rapida espansione. Oggi l’ansia sta conoscendo un nuovo momento d’oro, e di recente ha superato la depressione come disturbo più spesso diagnosticato negli Stati Uniti, con un ampliamento dei diversi tipi di ansia di cui è possibile soffrire (nella più recente edizione del manuale DSM-5, la bibbia delle diagnosi psichiatriche, ce ne sono dodici). Come nell’Ottocento, la diagnosi coinvolge più donne che uomini. Forse le donne sono più ansiose per natura? Oppure, dato che la maniera in cui la malattia è stata storicamente descritta è tanto chiaramente legata al gender, le donne avranno sempre più possibilità di soddisfare i criteri della diagnosi?
Per il filosofo danese Søren Kierkegaard, nato quarant’anni prima di Freud, l’idea dell’angoscia come un disordine psicologico generalizzato sarebbe stata difficile da tollerare. Lui credeva che non fosse possibile pensare all’esistenza umana senza comprendere le nostre emozioni, anche quelle più gravose. Parlava degli uomini come di creature tremanti, terrorizzate e ripugnanti — e una delle emozioni che gli interessava in maniera particolare era, in danese, la angest, una combinazione di angoscia per il presente e timore per il futuro. Con tutti i suoi a parte e le battute di spirito, i passaggi satirici e le digressioni, il trattato del 1844 Begrebet Angest (Il concetto dell’angoscia) è un tale labirinto che renderebbe ansioso chiunque al solo tentativo di leggerlo. Kierkegaard sostiene che l’angoscia è la reazione appropriata all’accorgersi che la vita non segue un ordine prestabilito, ma che, invece, noi abbiamo l’assoluta libertà di fare qualsiasi scelta vogliamo e la totale responsabilità di quanto poi ne risulta. «Chi volge gli occhi al fondo di un abisso è preso dalla vertigine», scrive Kierkegaard. Ma anche se questa vertigine può mettere i nervi a dura prova, la capacità di provarla è il segno di una vita vissuta con autenticità. A detta di Kierkegaard, soltanto «le persone prive di spirito hanno vissuto senza angoscia». La sfida per lui non era allora evitare il panico e l’agitazione per non esserne paralizzati, ma imparare a prenderne atto e comprendere il significato della scelta che la loro esistenza ci offre.
Quindi Kierkegaard troverebbe allarmante il modo in cui trattiamo l’ansia oggi, come un qualcosa da cui essere liberati, anziché come la prova della libertà stessa.
Solo una «prosaica stupidità», avvisava lui, avrebbe accantonato un sentimento tanto importante prendendolo per una semplice malattia.
Da: Tiffany Watt Smith, Atlante delle emozioni umane: 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, UTET, 2017.
Per approfondire:
* L’identificazione parziale o totale tra i termini italiani “angoscia” e “ansia” dipende molto dalle scuole psichiatriche o psicologiche chiamate in causa. A volte si distingue tra aspetti psichici e somatici della stessa emozione, a volte si fa un distinguo quantitativo (l’angoscia sarebbe un forte sentimento di ansia). Molte traduzioni italiane di Kierkegaard e Freud usano “angoscia” dove l’inglese usa il termine “anxiety”, che vale appunto sia per “ansia” che per “angoscia”; di contro, l’opera di Auden The Age of Anxiety viene tradotta come L’età dell’ansia. Ennesimo esempio, se ne servissero, della complicata trasmigrazione delle emozioni da una cultura all’altra [N.d.T.].
Prova uno dei nostri esercizi sull’Ansia:
Gli Esercizi di Meditazione sono riservati agli iscritti di livello Praticante e Contemplante.
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
You need to login or register to bookmark/favorite this content.



